
La IV Egloga
Durante l'ottobre del 40 a.C., mentre Virgilio scriveva l'opera, l'atmosfera nell'Urbe era molto tesa, e la guerra civile era al suo culmine: nel 40 a.C. Ottaviano e Marco Antonio si scontrarono nella cruentissima battaglia di Perugia e, dopo di essa, alcuni mediatori (Nerva, Mecenate, e lo stesso Pollione, amico di Virgilio e console in carica per quell'anno) riconciliarono i due triumviri, che stipularono quindi la pace di Brindisi; in base a questo trattato, ad Ottaviano fu assegnato l'Occidente, e ad Antonio l'Oriente; la penisola italica apparteneva ad entrambi. La tregua fu sancita con un matrimonio tra Ottavia, la sorella di Ottaviano, e Marco Antonio. Questa accordo fu salutato con grande speranza e gioia da parte dei veterani e degli abitanti di Roma, ed i due triumviri, tra il tripudio della folla, celebrarono l'ovazione.
Anche Virgilio, di solito lontano dalla vita politica, dimostra grande entusiasmo per questo accordo: nella IV Egloga, in particolare, con un registro stilistico notevolmente più alto rispetto alle altre, il poeta celebra l'imminenza del ritorno dei Saturnia Regna, in seguito alla nascita di un “bambino divino”, che avrebbe posto fine al tragico presente per inaugurare una nuova età dell'oro. Il poeta non fa il nome del puer, e il componimento assume così un tono profetico e misterioso. Secondo alcuni studiosi, questo bambino a cui, senza immaginare che sarebbe stata una femmina, Virgilio si riferisce, sarebbe il figlio derivante dall'unione tra Ottavia e Marco Antonio; secondo altre interpretazioni, potrebbe essere Asinio Gallo oppure Salonino, figli di Asinio Pollione, ipotesi questa concepita già dagli antichi commentatatori, o anche il nascituro figlio di Antonio e Cleopatra; gli amanuensi cristiani videro nel puer la figura di Gesù Cristo, e nella Virgo la Madonna, e questa interpretazione fece sì che per tutto il Medioevo Virgilio venne venerato come un saggio dotato di capacità profetiche; potrebbe rappresentare, infine, una metafora per indicare quel sogno di pace di una generazione disperata che sembrava in procinto di concretizzarsi con la pace di Brindisi. Un'altra interessante interpretazione è quella di Norden, che considera il puer come personificazione del "Tempo" che ricomincia il suo ciclo, a partire dalla favolosa età dell'Oro
Anche Virgilio, di solito lontano dalla vita politica, dimostra grande entusiasmo per questo accordo: nella IV Egloga, in particolare, con un registro stilistico notevolmente più alto rispetto alle altre, il poeta celebra l'imminenza del ritorno dei Saturnia Regna, in seguito alla nascita di un “bambino divino”, che avrebbe posto fine al tragico presente per inaugurare una nuova età dell'oro. Il poeta non fa il nome del puer, e il componimento assume così un tono profetico e misterioso. Secondo alcuni studiosi, questo bambino a cui, senza immaginare che sarebbe stata una femmina, Virgilio si riferisce, sarebbe il figlio derivante dall'unione tra Ottavia e Marco Antonio; secondo altre interpretazioni, potrebbe essere Asinio Gallo oppure Salonino, figli di Asinio Pollione, ipotesi questa concepita già dagli antichi commentatatori, o anche il nascituro figlio di Antonio e Cleopatra; gli amanuensi cristiani videro nel puer la figura di Gesù Cristo, e nella Virgo la Madonna, e questa interpretazione fece sì che per tutto il Medioevo Virgilio venne venerato come un saggio dotato di capacità profetiche; potrebbe rappresentare, infine, una metafora per indicare quel sogno di pace di una generazione disperata che sembrava in procinto di concretizzarsi con la pace di Brindisi. Un'altra interessante interpretazione è quella di Norden, che considera il puer come personificazione del "Tempo" che ricomincia il suo ciclo, a partire dalla favolosa età dell'Oro
pagina a cura del BUCOLICO



























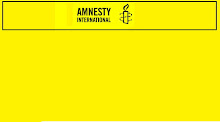
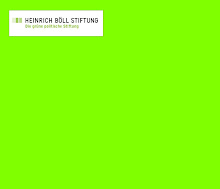
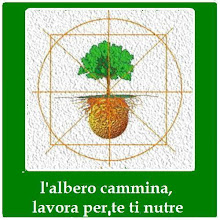
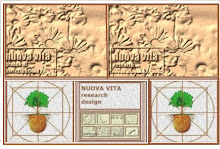










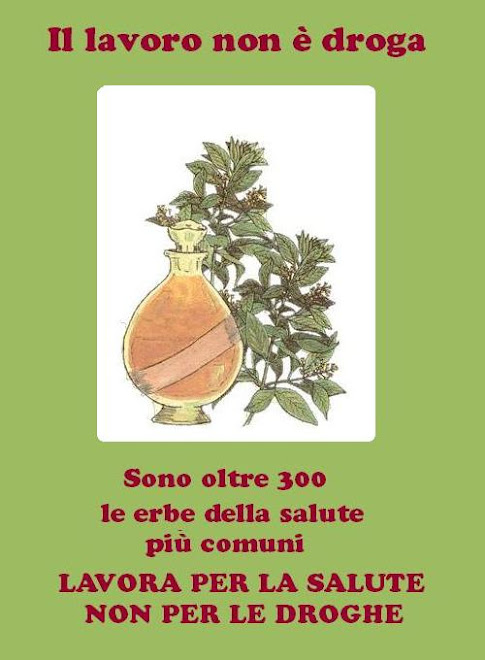









Nessun commento:
Posta un commento